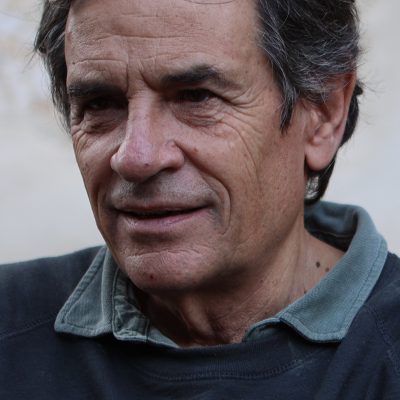Il desiderio di conoscere
Una ragazza di Roma mi racconta delle tesine preparate dalle sue compagne e compagni per l’esame di terza media. Una l’ha dedicata all’idea di perfezione, una a Pirandello e il doppio, una a ciò che le donne hanno fatto di grande e una al movimento, che collegava i movimenti politici ai movimenti del corpo e al movimento studiato in fisica. Il compito imponeva di azzardare connessioni ardite e forse improbabili, ma i temi li avevano scelti loro e questo era l’importante. Ciò che mi ha colpito, tuttavia, è stato il suo commento: “Perché solo nell’ultimo mese del triennio ci è stata data la possibilità di ricercare su un argomento deciso da noi, di raccontare qualcosa che ci riguarda? Un vero peccato, perché mi ha fatto scoprire delle cose delle mie compagne e compagni che non conoscevo”.
In questa semplice osservazione credo stia uno dei più grandi problemi della scuola. Se i saperi che noi insegnanti proponiamo non riescono a diventare un modo di conoscere se stessi e gli altri e di presentarsi al gruppo, se i metodi in cui li proponiamo non contemplano un’apertura alle diverse curiosità individuali a cui dare voce in continui dialoghi, se la cultura non ha modo di farci da specchio e mostrarci che ciò che accade dentro e fuori di noi può essere osservato da molteplici punti di vista, è inevitabile che troppe bambine e bambini, che arrivano pieni di curiosità e voglia di apprendere in prima, a sei anni, piano piano perdano il desiderio di conoscere ciò che propone la scuola, precipitando in alienazioni crescenti in cui tanti, troppi, annegano.
La scuola come luogo di cura
C’è una grande sofferenza che investe l’adolescenza e l’infanzia, che si è aggravata in modo impressionante negli ultimi anni. Dalla pandemia si è usciti con una rimozione totale, mentre quelle stagioni, in cui ogni contatto veniva assimilato al contagio, hanno segnato profondamente i corpi e le memorie dei più giovani. Il mondo adulto sembra dare prove di sé, sempre peggiori, sia per una diffusa adesione passiva allo spirito del tempo in cui odi e aggressività, guerre e discriminazioni sembrano prevalere, sia nella postura di troppi genitori, che alternano una pervasiva mania di controllo a intermittenze affettive e distrazioni continue.
In questo quadro cresce la solitudine di noi insegnanti, educatrici ed educatori, che spesso ci sentiamo inadeguati di fronte alle enormi difficoltà che incontriamo.
Per essere democratica e cercare di attenuare le troppe discriminazioni che attraversano la società, la scuola deve essere un luogo di cura. Cura delle relazioni reciproche e cura della relazione con il sapere. Luogo in cui si incontra certo la fatica dell’apprendere, ma dove quello sforzo viene sostenuto e alleviato da un contesto capace di dare senso e di permettere di superare gli ostacoli aiutati dagli altri. Luogo dove si sperimenta il pensare in gruppo e, soprattutto, si scopre che ascoltandosi e ragionando insieme si pensa meglio. Pratiche di scambio e reciprocità che nessuna intelligenza artificiale può sostituire.
Ora è evidente che noi che lavoriamo in campo educativo non siamo né psicologi né terapeuti. Ma poiché siamo costretti a confrontarci con le tante forme di malessere che abitano la scuola e la città, la sfida obbligatoria sta nel provare a rendere la cultura, nel senso più ampio del termine, spazio di cura e riconoscimento. Spazio in cui acquistare fiducia nelle proprie capacità, perché tutte e tutti abbiano l’occasione di dire con soddisfazione “gliel’ho fatta”. Per questo è necessario rallentare, moltiplicare i linguaggi, proporre meno e andare più in profondità, perché ciascuno possa trovare una sua via di accesso a un frammento di conoscenza presentato dalla scuola che non senta alieno da sé. Ma perché questo accada anche noi dobbiamo essere curiosi dei linguaggi, della musica, dei video e delle forme di scrittura e comunicazione che le nostre allieve e allievi praticano e frequentano.
Le nuove Indicazioni nazionali, commissionate da un ministro che vorrebbe introdurre forme di controllo e censura inaudite sui libri di testo, non vanno certo in questa direzione. Ma forse è proprio nella condivisione di iniziative di resistenza tra generazioni diverse, apparentemente assai distanti, che si può ripartire. Nel passato anche i tempi più bui hanno generato produzioni culturali capaci di aprire nuove strade.