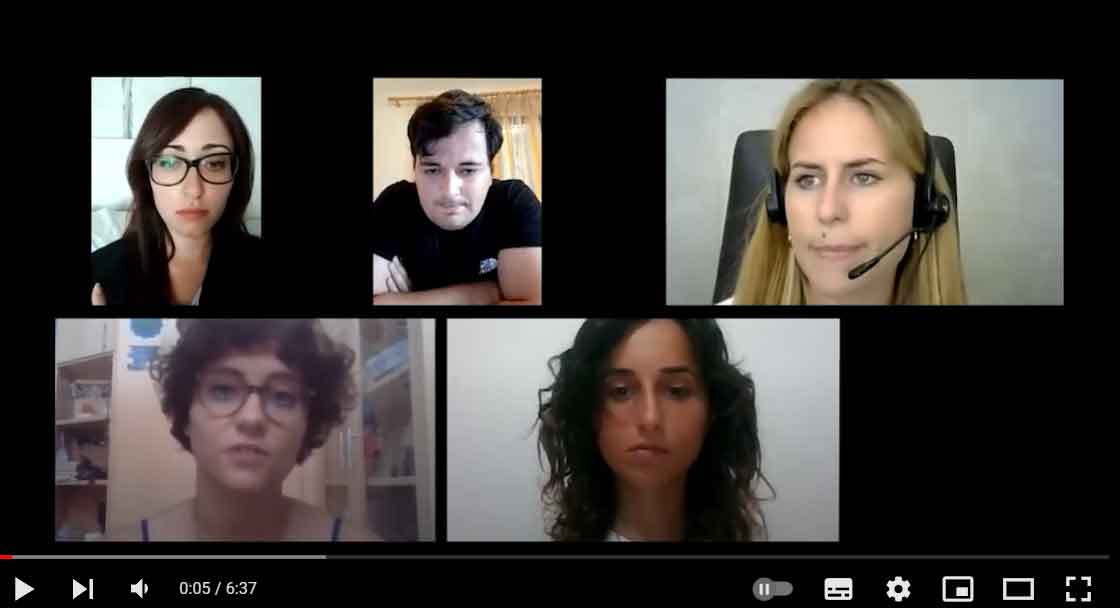Questo ventennale degli attentati dell’11 settembre 2001 offre lo spunto per varie riflessioni. E permette allo storico di provare a fare dei bilanci. Provvisori e ancora incompleti, che tanti documenti se mai accadrà li vedremo solo tra molto tempo; e inevitabilmente parziali, che le chiavi di lettura per comprendere la politica internazionale del XXI secolo sono plurime e complesse.
Difficile, all’11 settembre 2021, non individuarne però una nella crisi e contestazione di quei processi d’integrazione globale – di quella “globalizzazione” – che hanno per molti aspetti costituito la cifra distintiva dell’era contemporanea e che vent’anni orsono parvero essere sfidati, sì, ma ancora potenti e inelutttabili. La risposta degli Usa a quegli attacchi espresse, esasperò e in ultimo contribuì a indebolire se non a delegittimare una globalizzazione di suo contraddittoria e assai più vulnerabile di quanto allora non apparisse.
Perché essa poggiava sulla centralità, il primato e l’impegno degli Usa; e perché i diversi elementi della potenza degli Stati Uniti – le loro armi, la loro moneta, i loro consumi, i loro ideali, la loro retorica, la loro cultura – ne costituivano i pilastri fondamentali. Il mercato statunitense – e i consumi a debito degli americani – trainavano la crescita globale. Le forze armate degli Usa e la loro impareggiabile proiezione globale apparivano al servizio di una stabilità definita anche dalla capacità dell’egemone di preservare l’ordine e se necessario punire chi lo contestava.
Rivoluzione tecnologica
La rivoluzione tecnologica degli anni Novanta e la sua forte applicabilità parevano rilanciare il primato economico e culturale degli Usa. Le forme della governance globale, e i tempi e spazi della sua espansione – si pensi al caso dell’Organizzazione Mondiale per il commercio e al processo che avrebbe portato all’adesione della Cina completato solo tre mesi dopo gli attentati dell’11 settembre – sembravano essere dettati primariamente da Washington.
Sottotraccia vi erano contraddizioni acute in ognuno di questi ambiti. La potenza statunitense era immensamente superiore e funzionalmente indispensabile all’ordine del dopo Guerra Fredda. Ma nelle sue diverse declinazioni era anche fragile e contraddittoria: meno spendibile in un contesto globale contraddistinto da molteplici interdipendenze, che da un lato ne diminuivano l’importanza e dall’altro contribuivano a limitare la sovranità e l’autonomia d’azione dello stesso egemone.
La risposta all’11 settembre – oggi possiamo dirlo – quelle contraddizioni ha contribuito ad acuire e infine detonare. L’amministrazione Bush reagì con un’azione nella quale i mezzi erano precipuamente militari, i metodi fortemente unilaterali e la giustificazione scopertamente nazionalista. Sublimati in tanti discorsi presidenziali dei mesi post-11 settembre e ancor più in quello straordinario documento che è la Dottrina di Sicurezza Nazionale (National Security Strategy ) del 2002, questi elementi avrebbero plasmato strategie e politiche statunitensi, contribuendo a decretarne il fallimento ultimo e, con esso, a concorrere alla crisi della globalizzazione con la quale da tempo conviviamo.
La guerra al terrore
La “guerra al terrore” di Bush partì in Afghanistan per poi estendersi incongruamente in Iraq. Regimi da abbattere manu militari, quello talebano e di Saddam Hussein, per poi procedere a un’opera di ricostruzione e trasformazione presentata attraverso alcuni codici consolidati del discorso e dell’ideologia dell’internazionalismo statunitense: la modernizzazione e lo sviluppo; l’integrazione, politica, diplomatica ed economica; le libertà democratiche e i diritti umani. Su quest’ultimo punto la continuità con l’interventismo umanitario degli anni Novanta, di cui Afghanistan e Iraq dovevano essere un’altra tappa fondamentale, era evidente e continuamente affermato dal più fedele alleato di Bush, quel Tony Blair che si pose esplicitamente l’obiettivo di fare da trait d’union tra due epoche, pre e post-11 settembre.
abbattere manu militari, quello talebano e di Saddam Hussein, per poi procedere a un’opera di ricostruzione e trasformazione presentata attraverso alcuni codici consolidati del discorso e dell’ideologia dell’internazionalismo statunitense: la modernizzazione e lo sviluppo; l’integrazione, politica, diplomatica ed economica; le libertà democratiche e i diritti umani. Su quest’ultimo punto la continuità con l’interventismo umanitario degli anni Novanta, di cui Afghanistan e Iraq dovevano essere un’altra tappa fondamentale, era evidente e continuamente affermato dal più fedele alleato di Bush, quel Tony Blair che si pose esplicitamente l’obiettivo di fare da trait d’union tra due epoche, pre e post-11 settembre.
E però negli anni Novanta, dalla prima guerra del Golfo all’ex Jugoslavia, gli Usa avevano spesso agito per via multilaterale, cercando una qualche forma di legittimazione giuridica o diplomatica, per il tramite delle risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu o attraverso il coinvolgimento dei loro alleati. Lo stesso intervento in Kosovo vide la formazione di una solida maggioranza al Consiglio di Sicurezza, bloccata dalla certezza di un veto russo, e la piena partecipazione – importante per il suo significato politico ben più che per quello operativo – degli alleati NATO.
Nel dopo-11 settembre, il capitale di solidarietà internazionale fu rapidamente dissipato e la disputa sull’Iraq aprì una vera e propria voragine, in particolare dentro la Comunità Atlantica. La rivendicazione ostentata della possibilità, se non della opportunità, di agire soli e unilateralmente si accompagnò al dispiego di una sovraccarica retorica nazionalista. Utile, questa retorica, anche un ulteriore, problematico tassello della campagna anti-terroristica globale lanciata allora dagli Usa: quello rappresentato dalle modalità di cattura e gestione dei terroristi o sospetti tali.
Stato d’emergenza
Lo stato d’emergenza giustificò strumenti straordinari come la tortura, la rendition, e il trasferimento nel carcere speciale di Guantanamo. Strumenti necessari – nelle giustificazioni molto eccezionaliste che ne furono date – sia per la portata estrema della minaccia e delle forme con le quali era portata (i “combattenti illegittimi/unlawful combatants” nella definizione data allora del nemico) sia per la natura e la giustificazione di chi li utilizzava, gli Usa appunto.
L’unilateralismo contribuì a scardinare un sistema di governance globale di suo parziale e farraginoso. I metodi utilizzati, e più in generale i doppi standard e le ipocrisie dell’interventismo statunitense, screditarono l’idea che la comunità internazionale dovesse proteggere ed estendere i diritti umani, se necessario anche con l’uso della forza.
utilizzati, e più in generale i doppi standard e le ipocrisie dell’interventismo statunitense, screditarono l’idea che la comunità internazionale dovesse proteggere ed estendere i diritti umani, se necessario anche con l’uso della forza.
La guerra come strumento di modernizzazione e nation-building vide esposte una volta di più le sue contraddizioni. Un’America cinica e indurita, oltre che indisponibile ad accettare i costi umani e materiali di quelle guerre, ripose rapidamente le illusioni che la sua potenza, se adeguatamente dispiegata, potesse trasformare il mondo in accordo con gli interessi, i princìpi e gli ideali statunitensi.
Al di là del tentativo, velleitario e opportunistico, di Obama di rilanciare l’intervento in Afghanistan, tutte e tre le presidenze post-Bush Jr. – Obama, Trump e Biden – hanno rappresentato un tentativo di fare i conti con questo fallimento. Cercando di promuovere in forme diverse un graduale disimpegno accompagnato, soprattutto dopo il 2016, da un discorso anti-globalista vieppiù popolare e politicamente trasversale. Discorso, questo, che riflette a sua volta una crisi della globalizzazione alla quale ha contribuito anche il modo con cui gli Usa risposero agli attentati di vent’anni fa.