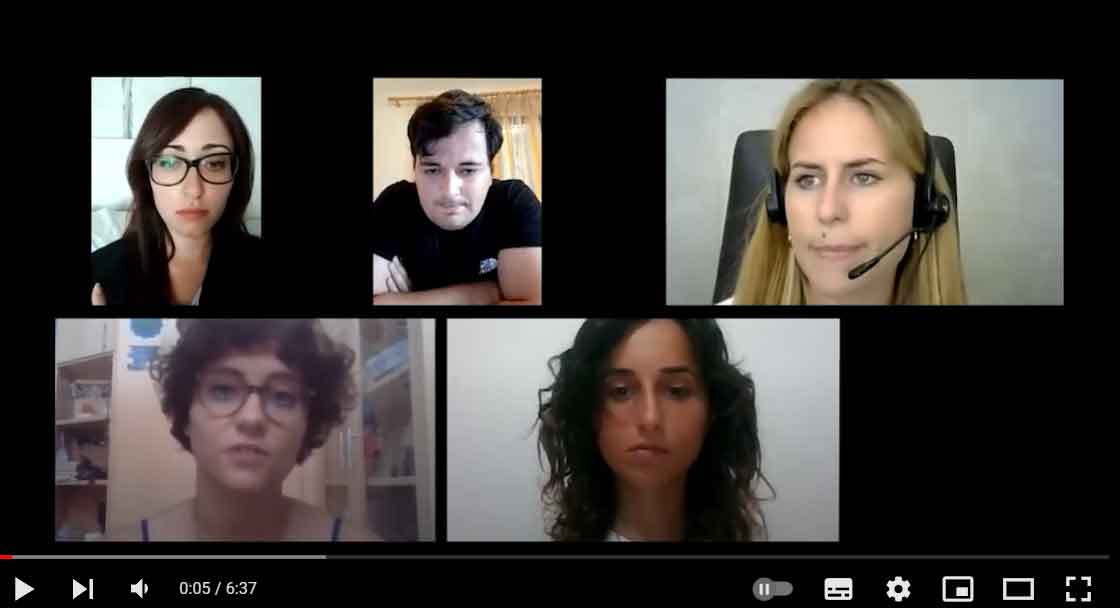Il 17 ottobre 1961 a Parigi, nell’indifferenza quasi generale, si consumò la più grave repressione poliziesca e razzista di una manifestazione nella storia dell’Europa dopo la Seconda guerra mondiale. La polizia aggredì sistematicamente e preventivamente un corteo disarmato e pacifico di algerini, con un bilancio impressionante: centinaia i morti e i dispersi, migliaia i feriti, undicimila i fermi.
Il terrore di stato del prefetto Papon
Per capire l’evento e il silenzio che l’ha avviluppato nei decenni successivi occorre allargare la focale al contesto: l’esplosione del 17 ottobre non è infatti il risultato di circostanze eccezionali e fortuite ma il culmine parossistico di una violenza di stato organizzata nei mesi e negli anni precedenti, nel quadro dell’aspra guerra che i francesi conducono dal 1954 contro gli indipendentisti algerini del FLN, il Fronte di liberazione nazionale.
Sul territorio della métropole, la polizia francese ha infatti importato le tecniche di «mantenimento dell’ordine» messe a punto in Algeria e le categorie coloniali sono correntemente utilizzate per inquadrare i 350.000 algerini che vivono in Francia.
Benché ufficialmente francesi a tutti gli effetti, il sistema di cittadinanza differenziale li categorizza come «nord-africani» o «indigeni».
Questi lavoratori vivono in condizioni di estrema povertà, concentrati soprattutto in baraccopoli alla periferia delle grandi città, come la bidonville di Nanterre, a ovest di Parigi, che nel 1960 ha 14.000 abitanti. L’inquadramento della comunità immigrata diventa un elemento chiave per la Federazione di Francia del FLN che intende così affermare la propria legittimità politica e allo stesso tempo finanzia la guerra in Algeria attraverso una colletta obbligatoria (l’80% dei fondi del Governo provvisorio della Repubblica algerina provengono da questa «imposta rivoluzionaria»). Per contrastare questo «contro-potere», lo stato francese inasprisce ulteriormente le misure repressive in particolare con la creazione di corpi speciali di polizia preposti al controllo dei «francesi musulmani».
In questa escalation, la nomina di Maurice Papon a capo della prefettura di polizia di Parigi, nel marzo del 1958, segna un salto di qualità. Prefetto di Costantina, in Algeria, prima di arrivare a Parigi (1956-58), Papon conosce bene la «questione algerina». Per spezzare l’organizzazione politico-amministrativa del FLN, crea un’unità speciale, la Forza di polizia ausiliaria (FPA), composta da 300 algerini che hanno combattuto contro il Fronte in Algeria e sono avvezzi alle tecniche della «guerra contro-rivoluzionaria».
Ma soprattutto la FPA risponde direttamente al prefetto, ed è così libera di agire al di fuori di ogni vincolo legale: soprannominati gli «harkis della polizia», in riferimento ai suppletivi assoldati dall’esercito francese in Algeria, gli uomini della FPA agiscono con violenza brutale, praticando anche la tortura (nella memoria degli algerini sono tristemente famose le cantine del commissariato del quartiere della Goutte d’Or, al nord di Parigi). Questi metodi illegali sono accompagnati da un sistema di campi di detenzione dove si può essere internati per semplice via amministrativa, senza l’avallo del giudice.
Il FLN, che nell’agosto 1958 ha aperto un secondo fronte colpendo la Francia sul suo stesso territorio (sabotaggi e attacchi ai depositi di carburante), tra agosto e ottobre 1961 organizza una serie di attentati in particolare contro gli uomini della Forza di polizia ausiliaria, uccidendo 11 poliziotti e ferendone 17. Con l’avallo del primo ministro Michel Debré e del ministro dell’Interno Roger Fey, Papon scatena una risposta durissima, garantendo copertura ai suoi uomini a cui dice: «per ogni colpo ricevuto, ne renderemo dieci». Il messaggio è chiaro e sin da settembre si cominciano a ripescare dalla Senna decine di cadaveri di algerini. Il 5 ottobre, Maurice Papon istituisce inoltre un coprifuoco dalle 20:30 alle 5:30, mentre i bar frequentati dagli algerini di Francia devono chiudere alle 19.

17 ottobre: la sfida degli algerini nel cuore di Parigi
Per rispondere all’offensiva Papon-Debré-Frey, e contestare un coprifuoco razzista perché valido solo per i «francesi musulmani d’Algeria», il FLN organizza una grande manifestazione. Si tratta anche di dare una dimostrazione di forza mentre sono in corso i negoziati che porteranno alla fine della guerra e all’indipendenza dell’Algeria.
Il 17 ottobre è martedì e a Parigi piove. Verso le 19, gli algerini cominciano a dirigersi, a piedi o in metro o in bus o con qualsiasi altro mezzo, verso i punti di concentramento stabiliti. Sono disarmati. Il FLN ha impartito regole rigidissime: niente armi, anche i temperini da tasca devono restare a casa. Il servizio d’ordine perquisisce i gruppi che partono dalle bidonville.
I manifestanti sono per lo più operai. Si sono vestiti bene, con l’abito da festa. Vanno in famiglia, con i figli e le donne che fanno risuonare i loro youyou. Sono probabilmente impauriti (andare alla manifestazione è comunque obbligatorio), ma anche in qualche modo orgogliosi della sfida che portano al cuore di Parigi, uscendo allo scoperto con dignità contro un potere che fa di tutto per disumanizzarli, per umiliarli.
Gli algerini sono 20-30.000, forse di più. Molti non raggiungeranno mai i punti di concentramento. La polizia, che pure sa che il FLN ha organizzato una dimostrazione pacifica, li attacca preventivamente e con inaudita violenza: i manifestanti sono soprattutto colpiti con i bidules, i bastoni di legno lunghi un metro in dotazione alla polizia, ma gli agenti non esitano a sparare a più riprese sulla folla. Ci sono scene di caccia all’uomo di rara ferocia e molti algerini sono gettati giù dai ponti nella Senna (quasi nessuno sa nuotare). I pestaggi e le violenze continuano anche nei commissariati e nei bus che portano gli algerini verso gli stadi della città adibiti a centri di detenzione.
A mezzanotte, dice un comunicato di polizia, «la calma è ritornata ovunque». La versione ufficiale parla di un regolamento di conti fra algerini che poi avrebbero aperto il fuoco contro le forze dell’ordine e dà un bilancio di due morti e qualche decina di feriti.
Come ogni repressione coloniale è difficile stabilire una contabilità esatta dei morti e dei dispersi, a ulteriore dimostrazione che quella dei «francesi musulmani d’Algeria» è una sottocategoria a parte, imprigionabile e uccidibile a piacimento. Le ricerche più recenti e affidabili, come quelle degli storici inglesi Jim House e Neil MacMaster, tendono a considerare un ciclo repressivo che si protrae lungo i mesi di settembre e ottobre, durante i quali sarebbero stati uccisi almeno 120 algerini.
I dispersi sono altrettanti. Molti furono inviati in Algeria in campi di detenzione con tassi di mortalità altissima, e non se ne è saputo più nulla. Sono invece 14.000 gli algerini posti in stato di detenzione tra il 17 e il 19 ottobre. Contrariamente alle intenzioni di Papon, le violenze della «battaglia di Parigi» invece di stroncare il movimento nazionalista contribuirono a rafforzarlo in maniera decisiva.
La memoria: una bomba a scoppio ritardato
Possiamo identificare grosso modo tre fasi relativamente all’elaborazione della memoria del 17 ottobre 1961 nella società francese. La prima fase è quella del silenzio, della rimozione, e va dal 1961 fino all’inizio degli anni 1980. Nel 1983, la Marcia per l’eguaglianza e contro il razzismo mette in evidenza la maturità politica dei figli dei manifestanti del 17 ottobre che riscoprono la storia dei genitori e cominciano a chiedere verità e giustizia.
La seconda fase va dunque dall’inizio degli anni 1980 ai primi anni 1990 ed è caratterizzata dal lento emergere di questa memoria ritrovata, portata da un tessuto in espansione di associazioni e collettivi politici che non mancano di sottolineare la conturbante continuità tra il massacro del 17 ottobre 1961 e gli abusi della polizia nei quartieri poveri ai margini dei grandi agglomerati urbani abitati principalmente da francesi non bianchi. Segna indubbiamente l’acme di questa fase la pubblicazione del libro di Jean-Luc Einaudi (La Bataille de Paris, 1991) ricco di testimonianze registrate in Francia e in Algeria e che smentisce, documenti alla mano, la versione governativa dei “soli” due morti.
La terza fase si apre alla fine degli anni 1990 e vede Einaudi ancora protagonista. Nel 1997-98, durante il processo contro Maurice Papon per la sua responsabilità, in qualità di prefetto di Bordeaux, nella deportazione di 1.600 ebrei della Gironda tra il 1942 e il 1944, le associazioni ebraiche costituitesi parti civili chiamarono a deporre Jean-Luc Einaudi per far luce sull’operato dell’imputato quando era prefetto di Parigi. Il processo segna un passaggio decisivo nel dibattito pubblico francese dall’ossessione sugli «anni neri» del regime collaborazionista di Vichy alla sequenza coloniale e alle sue eredità postcoloniali.
Come il presidente Jacques Chirac, nel 1995, aveva riconosciuto che bisognava guardare alla vicenda «irreparabile» di Vichy e della deportazione degli ebrei come parte integrante della storia della Francia, così da più parti si cominciava ora a chiedere la stessa assunzione di responsabilità anche per il massacro del 17 ottobre 1961 e più in generale per la guerra d’Algeria e la colonizzazione.
Negli ultimi anni è andata crescendo con forza la domanda di un riconoscimento ufficiale del 17 ottobre e contestualmente del razzismo strutturale che informa le pratiche di mantenimento dell’ordine nei quartieri popolari.
Le statistiche ci dicono che un giovane nero ha nove possibilità più di un coetaneo bianco di essere fermato dalla polizia. Questi «controlli d’identità» avvengono dunque in base a criteri etno-razziali discriminanti. Nove volte su dieci i controlli si concludono con un niente di fatto.
Quando ci sono conseguenze, nella stragrande maggioranza dei casi i giovani sono fermati per «resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale», che è spesso il risultato a cui mirano queste operazioni umilianti e degradanti.
Nel 2020, l’agonia di George Floyd soffocato da un poliziotto bianco e il movimento Black Lives Matter che ne è seguito hanno avuto una profonda eco in Francia, dove lo stillicidio di non bianchi provenienti dalle classi popolari uccisi dalla polizia non si è mai arrestato, da Zyed Benna e Bouna Traoré, 17 e 15 anni, morti nel 2005, fino ad Adama Traoré, 24 anni, morto nel 2016. Ogni volta torna, sempre con maggiore forza, il riferimento al 1961. E ogni volta sembra che troppo poco sia cambiato.

This project has received funding from the MSCA under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program [grant agreement No 837297]