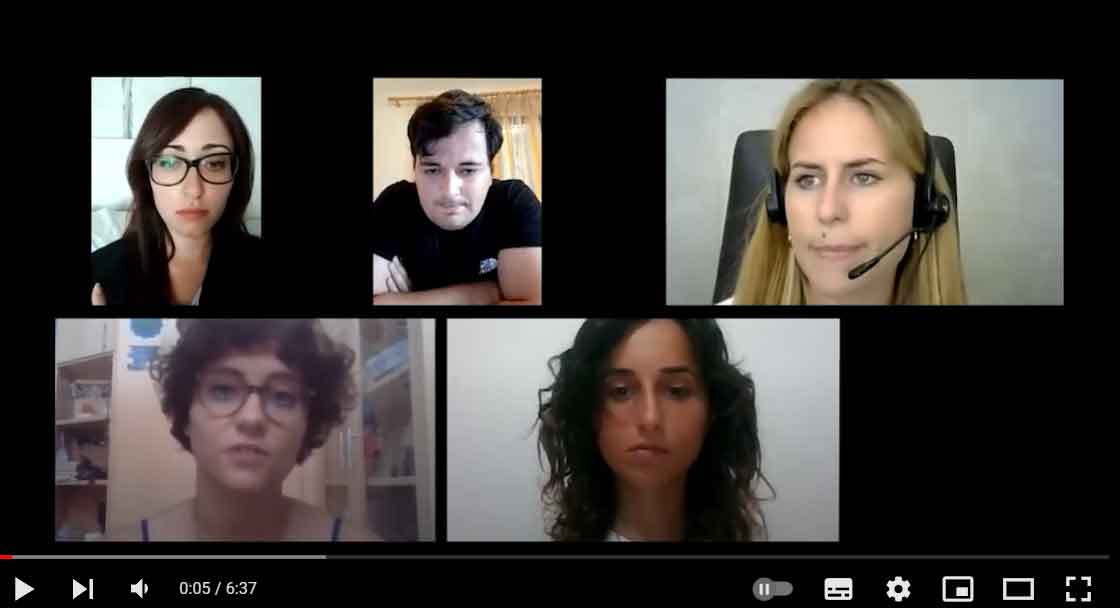Norberto Bobbio ha affermato che dalla storia abbiamo imparato poche cose:
“che le idee si condensano in un sistema di ortodossia, i poteri in una forma gerarchica e ciò che può ridare vita al corpo sociale irrigidito è soltanto l’alito della libertà”; inoltre, che a salvarci, nei periodi più bui della Repubblica sia stato il riuscire a guardare quella stessa storia dal punto di vista degli oppressi.
Questi due assi proposti dal filosofo e giurista sono la lente con cui si può leggere, ancora oggi, la ricorrenza del 25 aprile, trovando in tali parole un senso concreto, non solo come esercizio di memoria, ma come pratica politica del presente.
Pensare la liberazione come l’alito della libertà e, al contempo, schierarsi dalla parte degli oppressi sono la sintesi del percorso democratico degli ultimi 77 anni. La fine della guerra ha rappresentato il prodromo ma non l’unica condizione per un’esistenza di libertà. La liberazione è stata (e forse rimane) un processo in divenire, che inizia con l’emozione avversa nei confronti dell’oppressione e che costruisce, stratifica e difende gli strumenti di libertà, proprio a partire dal quel 25 aprile 1945. Questi percorsi e il senso di quel giorno si ritrovano nelle parole di Pietro Secchia, detenuto, confinato e poi costituente repubblicano.
Sebbene il carcere abbia mantenuto la funzione di gestione della devianza e marginalità sociale in modo ininterrotto in tutta la storia dello stato liberale, nel ventennio la pena detentiva è stato lo strumento principe per prevenire e reprimere qualsiasi forma di opposizione politica[1].
Un potere (auctoritas) che veniva esercitato non basandosi sui fatti (veritas) ma sulle pratiche di sospetto e sulla volontà politica.
La detenzione
La detenzione si applicava in due circostanze: per contrastare le forme di opposizione occasionali (come manifestazioni singole, o precise iniziative) in cui al dissidente venivano attribuite responsabilità per i reati comuni acquistando in concreto una forma politica nel momento dell’arresto (utilizzando il paradigma del criminale per colpire il “nemico”) e per gestire le persone condannate davanti al Tribunale speciale per la difesa dello Stato[2], che si occupava delle forme clandestine di opposizione politica organizzata (identificando e neutralizzando i nemici attraverso la detenzione).
Spesso al carcere faceva seguito la misura di sicurezza amministrativa del confino, come estensione della privazione della libertà in forme differenti[3], e proprio per la sua natura non codificata dal diritto penale, poteva avere maggiori margini di discrezionalità. Infine, era prevista per i casi più gravi, la pena di morte[4].
Queste misure venivano definite, non a caso, come “Provvedimenti per la difesa dello Stato”[5].
In qualche modo, il carcere è la materializzazione di tale potere statale, indirizzato a riallacciare la relazione col cittadino, che è alla base della “correzione” pensata dal regime. Si tratta di un percorso orientato a trasformare i reclusi “prima in detenuto modello, poi in cittadino probo e infine in fascista perfetto”.
Più poeticamente, come affermava Pavese, “la prigione consiste nel diventare un foglio di carta”: la punizione permette così di riscrivere attraverso la correzione, l’adesione agli ideali. Non a caso, i volumi dell’allora ministro della giustizia Dino Grandi pubblicati nel 1941 sui successi del regime in ambito carcerario sono intitolati “Bonifica umana”.
Secchia stima che il regime abbia privato della libertà 33000 persone tra deferiti, processati dal Tribunale speciale e confinati per ragioni politiche. Per Secchia è proprio il carcere, così come il confino[6], a diventare laboratorio politico, in cui i quadri della resistenza si incontrano, si formano e maturano quel processo di trasformazione che porterà a reclutare quasi 200.000 partigiani dopo l’8 settembre 1943.

Legame tra antifascismo e lotta di classe
Nonostante la forza del regime, Secchia attribuisce agli spazi del penitenziario il rafforzamento del legame tra antifascismo e lotta di classe, grazie alla prossimità forzata tra ladruncoli comuni, diseredati, poveri a dissidenti politici.
Secchia, proprio tra le mura del carcere, luogo di massima privazione della libertà, parla della formazione dell’esercito che porta libertà nel nome. “L’esercito della libertà” si organizza in carcere, e non a caso non si tratta di un “esercito di liberazione”.
Viene da pensare che la distinzione stia proprio nella relazione col potere dei detenuti “sovversivi”. Perché l’esercizio politico svolto nelle celle e nei buglioli, nei corridoi e nelle vie del confino fatto di “pareti d’aria”[7]non è tanto teso alla liberazione (dalla prigionia) ma alla tensione ribelle nei confronti del disciplinamento. Quello studiare, quel pensare, quel costruire relazioni, quel non piantare le patate di cui racconta Secchia è già di per sé un esercizio di resistenza, nel senso letterale del termine. Perché la questione centrale, che rende così attuali le parole di quei resoconti, non è la liberazione dei corpi, bensì il non disciplinamento dei pensieri. In tal senso, la Resistenza inizia con gli arresti, e va anticipata rispetto all’8 settembre.
“Resistere” contiene la particella re, addietro, e sistere, con il raddoppiamento della radice di stà-re, star fermo, star saldo. È la libertà di pensiero che Secchia, così come i compagni di prigionia, mantengono ferma, è a quell’alito di libertà che rimangono saldi, che resistono.
Università della Resistenza
Se Secchia racconta come quegli anni siano stati il laboratorio di una vera e propria “università della resistenza” in cui i detenuti e i confinati hanno utilizzato la privazione della libertà per studiare tanto il materialismo storico quanto le tecniche militari, è interessante in questa occasione interrogarsi come quell’esperienza abbia trasformato il rapporto col carcere nel passaggio dalla dittatura alla repubblica. Rileggere quelle pagine significa ricucire le fila di diverse storie: da una parte gli anni della guerra hanno visto il carcere come dispositivo di potere seguire i cambiamenti di governo[8].
Dopo il 25 luglio 1943 tra le mura di san Vittore si ritrovarono (divisi in differenti corridoi) tanto detenuti comuni, quanto detenuti politici quanto ancora gerarchi fascisti imprigionati. Non solo, lo stesso Mussolini viene confinato prima a Ventotene, e poi trasferito per motivi di opportunità e sicurezza a Ponza[9]. Il carcere “bonifica umana”, il carcere come strumento di governo degli indesiderati e di gestione dei nemici durante la guerra rivela la sua funzione più nascosta ossia l’esercizio della coercizione e del potere – non mediato – dello Stato sui cittadini, assecondando i voleri di chiunque lo eserciti.
La consapevolezza di quell’esperienza, iscritta nei corpi e nelle biografie di molti fautori della liberazione permette oggi di comprendere meglio l’intento dei costituenti quando decisero di disciplinare la detenzione nel testo Costituzionale, vincolando così la volatilità politica dei codici alle garanzie proprie della democrazia. Un intento che si ritrova nei lavori dell’assemblea costituente, e negli attuali articoli della Costituzione ancora vigenti.[10]
In particolare, assume un significato più pregnante il quarto comma dell’art. 13, “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta`”, il “Nessuna restrizione può` essere determinata da ragioni politiche” dell’ art. 16; e ancora “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” dell’art. 27.
Intervento della Costituente
I costituenti, che avevano ben in mente i rischi della dittatura e le sue espressioni più violente nelle forme della detenzione, avevano puntellato la carta di tutele, tese a mitigare le strutture dell’oppressione (politica, ma anche quelle dettate dalle diseguaglianze, come ben esplicita l’art.3) e preservare attraverso la Carta L’alito della libertà. La privazione della libertà – proprio perché conosciuta – viene pertanto definita e ridotta all’osso, ai soli casi necessari, e comunque la coercizione viene limitata dal “senso di umanità”.
Non vengono nemmeno enunciati i trattamenti “crudeli e disumani” proprio per non offrire il pretesto nominale per utilizzarli[11]. Allo stesso modo, nella versione finale si elide persino il concetto di “dignità” ad accompagnare “umana” proprio per ridurre il potere coercitivo alla sua forma più essenziale. Non solo, proprio per mitigare la funzione retributiva della punizione, viene esplicitato il principio della rieducazione come tensione della pena detentiva, e quindi come “esperienza democratica” tesa a bilanciare l’esperienza della coercizione del potere.
In qualche modo, i costituenti hanno creduto nel mai più dell’esperienza bellica, e immaginato forme di potere democratico dissimili dall’esperienza della dittatura anche in uno spazio di potere per definizione, come il carcere.
Sebbene (anche nei periodi più bui degli anni di piombo) la detenzione abbia tendenzialmente mantenuto il suo orientamento costituzionale, gli anni recenti hanno mostrato come l’incuria e la negligenza nella tutela dei diritti negli spazi di privazione della libertà abbiano avuto riverberi significativi per il penitenziario in primis, e più generale per la tenuta democratica. Dalla condanna per violazione dell’ art. 3 della Corte Europea dei diritti dell’Uomo per il sovraffollamento con la sentenza Torreggiani (“trattamento inumano e degradante”) alle prime applicazioni della recente legge sulla tortura (introdotta nel 2017), fino alle incredibili immagini degli abusi di Santa Maria Capua Vetere, assistiamo alla fragilità del garantismo in presenza di una mancanza di investimenti culturali e materiali sul penitenziario.
Come ha sostenuto Rodotà, la rieducazione contiene un paradosso, ossia fondare una trasformazione nell’esperienza dei diritti su una privazione (di libertà), che spesso viene accompagnata ad altre violazioni, nella più generale “economia dei diritti sospesi” che caratterizza il penitenziario. Appare ancora più importante, oggi, rileggere le pagine di Secchia, per comprendere come guardare al penitenziario significhi guardare alla democrazia: non solo perché ci si deve tutelare dalle forme di esercizio del potere che si possono rapidamente tramutare in oppressione, ma anche perché l’alito della libertà (e lo stato della democrazia) va preservato proprio dove è più fragile, dove il corpo sociale si irrigidisce e gli anticorpi resistenti si fanno più necessari.
Note
[1] Come ha affermato Guido Neppi Modona, soprattutto perché “Per la prevenzione e repressione di specifici comportamenti devianti si ricorre a sistemi alternativi alla giustizia penale ordinaria, quali, per l’opposizione politica, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato e la misura amministrativa del confino di polizia”“La pena nel ventennio fascista”, Treccani, 2012.
[2] Organo militare di giustizia politica appositamente istituito nel 1926, avente unica sede in Roma.
[3] Diverso, e solo parzialmente connesso al sistema di detenzione è il meccanismo del campo di concentramento che in Italia si attiva solo nelle fasi proprie della guerra. Paradigmatica, in tal senso, la trasformazione del campo di Fossoli da campo di prigionia a campo di smistamento.
[4] In tempo di pace, dal 1926 al 1940, il Tribunale speciale ha giudicato 5619 imputati, di cui 4596 condannati, per un totale di 28.000 anni di galera, e ha pronunciato 9 condanne a morte, senza tenere conto di quelle, ben più numerose, emesse successivamente contro nazionalisti e irredentisti croati e sloveni (Neppi Modona 2007, p. 349; Tessitore 2000, pp. 293-316).
[5] Sebbene questa distorsione sia propria della dittatura, il carcere ha sempre avuto una funzione politica anche nei periodi di quiete. Michel Foucault ha ben spiegato come la funzione correzionale trovi la sua origine nelle c.d. “lettre de cachet” usate dal re francese per controllare i gruppi spontanei, e che stabiliva il rilascio dalla detenzione sulla base del ravvedimento, ritenute da Foucault la base dell’idea di imprigionare per correggere (Foucault 1997).
[6] Come ha affermato Guido Neppi Modona, nella sua voce “La pena nel ventennio fascista” erano destinatari della misura di sicurezza del confino “oltre a mafiosi e camorristi, le più disparate categorie di oppositori: comunisti, anarchici, socialisti, appartenenti a Giustizia e libertà, esponenti liberali e cattolici, e anche semplici disfattisti”.
[7] “Viveva in mezzo a pareti d’aria” è la descrizione del confino a Brancaleone Calabro di Cesare Pavese, così come descritto in “Carcere”.
[8] Come ha raccontato Christian de Vito in Camosci e Girachiavi, “ La gestione delle carceri, come ogni altro aspetto della vita civile, amministrativa e politica tra il 1943 e il 1945, fu pesantemente condizionata dalla situazione bellica”.
[9] Il 28 luglio 1943 Benito Mussolini giunse nel piccolo porto di Ventotene, ma il direttore della colonia, Marcello Guida, per ragioni di sicurezza, considerata la presenza di quasi novecento confinati e della bene armata guarnigione tedesca, (che si occupava di un potente radar) decise di non accogliere. La corvetta si diresse allora verso la vicina Ponza, dove Mussolini si ritrova, quasi 30 anni dopo, in privazione della libertà con Pietro Nenni.
[10] è il 25 gennaio 1947 quando in sede dell’assemblea costituente si discute dell’art. 27, e di carcere e pene. Il segretario e il dattilografo riportano due emendamenti di Giovanni Leone. “Il primo ha carattere puramente formale”, “egli propone infatti di sostituire le parole: “e non possono ricorrere a trattamenti crudeli e disumani” con le seguenti: “e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, Col secondo emendamento propone che la pena di morte sia abolita soltanto per i reati politici.
[11] Dai lavori preparatori: “E ancora Nobile afferma: È sembrato che parlare di « trattamenti crudeli ·e disumani» dia quasi il pretesto per usarli e ritiene perciò molto più rispondente ed ampia la formula: « Le pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignità umana»”.