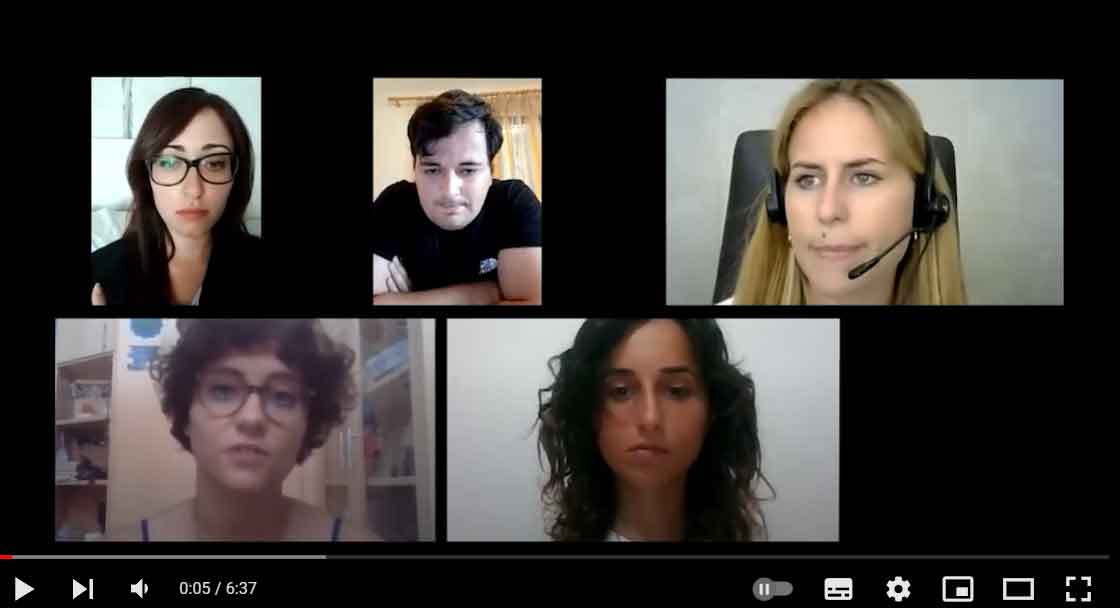Le recenti sfide interne ed esterne che l’Europa sta attraversando hanno dimostrato quanto sia necessario formare quella che Habermas ha definito “opinione pubblica europea”. Per questo è necessario investire sulla visione del passato con cui sono educati, o diseducati, i cittadini europei
Il titolo iniziale del volume che ho curato con Bolaffi era Per un calendario civile europeo: si poneva il compito, molto “preliminare”, di sollevare dei dubbi sulle differenti prospettive nazionali con cui tuttora si guarda alla storia del ‘900. In realtà sottovalutavamo fortemente il fatto che altri – soprattutto nell’Europa post-comunista – lavoravano e lavorano per costruire “calendari civili”, diciamo così, nazionalistici, imponendoli non solo con la forza dello Stato ma anche con il consenso di visioni storiche diffuse: spesso memorie tenacemente conservate all’interno dei regimi comunisti e riemerse tumultuosamente nel loro crollo.
Visioni che diventano talora vere armi di guerra e che comunque sono uno strumento potente nelle mani di regimi “sovranisti”. Da questo punto di vista sembrano esserci grosso modo tre fasi nel rapporto fra le differenti memorie europee, e forse ci eravamo illusi che continuasse all’infinito la fase “progressiva” dei primi decenni, connessa al “mai più guerre fra noi” della “dichiarazione Schuman”.
La caduta del muro
Scandita dal percorso che conosciamo: dalla messa di riconciliazione di De Gaulle e Adenauer nella Reims del 1962 (l’anno dopo vi sarà il Trattato franco-tedesco dell’Eliseo) sino a Mitterand e Kohl a Verdun, e così via. Con la caduta del Muro questo percorso sembra allargarsi, misurandosi anche con la grande ferita delle espulsioni di milioni di tedeschi dall’Europa centro-orientale: l’appello dei vescovi polacchi a quelli tedeschi della metà degli anni Sessanta (“noi perdoniamo e chiediamo perdono”) è raccolto negli anni Ottanta da intellettuali ed esponenti di Solidarnosc. Nel 1994 vi fa riferimento esplicito il presidente tedesco Herzog in visita a Varsavia: “Incontriamoci, chi ha bisogno di perdono e chi è pronto a perdonare. Noi, ex nemici, vi condurremo nell’Europa unita”.
Percorso che si incrina talora per le spinte divaricanti alimentate dalle organizzazioni dei Vertriebenen in Germania e dal partito Diritto e Giustizia in Polonia, ma comunque prosegue, e credo che meriterebbe un’attenzione specifica – al di là anche della sua influenza effettiva – il manuale tedesco-polacco conclusosi nel 2020.
Ancora più interessanti i rapporti fra polacchi e ucraini dopo le lacerazioni della guerra e del dopoguerra: qui la via al dialogo è aperta sin dagli anni Settanta da una rivista dell’emigrazione polacca, Kultura, ed è proseguita poi da Solidarnosc. Michnick porterà il suo sostegno all’indipendenza ucraina già nel 1989 al congresso di fondazione del Rukh (e la Polonia sarà poi il primo Paese a riconoscerla). È l’inizio di un percorso che ha conosciuto, anche qui, battute di arresto e passi indietro (ivi compresa la riabilitazione ucraina di Stepan Bandera), ma oggi è difficile non comprenderne l’importanza.
Rapporti fra Germania e Cecoslovacchia
Percorsi in qualche misura simili hanno segnato anche i rapporti fra Germania e Cecoslovacchia (va in Germania Havel all’indomani della sua elezione e chiede perdono per le espulsioni del dopoguerra: un gesto tanto alto quanto impopolare in patria). Processi di dialogo, ma in quello stesso torno di tempo iniziano anche le lacerazioni che dilaniano la Jugoslavia. “Il totalitarismo comunista – dice Michnick nel 1990 – lascia in eredità anche il nazionalismo aggressivo e l’odio tribale”, mentre la Heller leggeva quelle guerre come “guerre del ricordo”, con il riemergere feroce di memorie nazionalistiche che la Jugoslavia di Tito aveva “vietato” ma non certo cancellato.
Difficile trovare esempi più limpidi dell’ uso della storia come arma di guerra, e di “costruzione della nazione” secondo i parametri “ottocenteschi” del martirio, della persecuzione da parte dell’“Altro” e del proprio eroismo, con l’intrecciarsi di celebrazioni, monumenti (e distruzione di centinaia monumenti e targhe alla Resistenza in Croazia), riscrittura dei manuali scolastici, e così via. Con i problemi che si pongono poi all’indomani di quelle guerre ma anche con l’impegno in controtendenza di gruppi e associazioni di insegnanti, sia pur molto minoritari (con il sostegno dell’Istituto Eckert, del Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, di Euroclio e delle istituzioni europee e così via).
Dell’uso della storia come arma di guerra la Russia di Putin è naturalmente esempio fulgido, in un percorso costruito da più di vent’anni: con grande attenzione anche in questo caso all’insegnamento e con forti sintonie con strati profondi della popolazione. Non è necessario però giungere a questi estremi, basta pensare alle pulsioni nazionalistiche e antieuropee alimentate dalla “politica della storia” apertamente dichiarata da Diritto e Giustizia in Polonia o praticata da Orbán in Ungheria.
Una pedagogia dell’onore e dell’orgoglio nazionale
Una politica della storia che ha non poche consonanze in parti ampie della Polonia (lo riconoscono anche i suoi oppositori). Una “pedagogia dell’onore e dell’orgoglio nazionale” contrapposta alla “pedagogia della vergogna”, cioè alla storia critica, nella prosa di Diritto e Giustizia (sullo sfondo vi è anche il dibattito provocato da I carnefici della porta accanto di Gross). Una pedagogia che comprende anche la negazione per legge delle responsabilità polacche nella Shoah, l’omaggio alla Brigata Santacroce che combattè al fianco dei nazisti o l’apologia dei “soldati maledetti” che continuarono a combattere sino ai primi anni Cinquanta.
Comprende, soprattutto, gli attacchi durissimi a chi tenta la via di una storia pluralistica e di respiro internazionale: è esemplare la vicenda del Museo della Seconda guerra mondiale di Danzica, realizzato negli anni del governo Tusk e pesantemente snaturato dopo il ritorno al potere della Destra. Infine, della “politica della storia”di Orban è testimonianza viva la Casa del terrore di Budapest, e Orbán è l’unico leader politico vivente che usi nella sua propaganda un Trattato di oltre un secolo fa.
È possibile poi solo evocare i nodi connessi al ruolo della Shoah e del gulag nella storia del Novecento. Ancora il mese scorso la premier estone Kaja Kallas ha ripreso praticamente alla lettera quel che diceva nel 2005 la Presidente lettone prendendo le distanze dalle celebrazioni moscovite del 9 maggio, disertate da Estonia e Lituania. Per noi non è un momento di gioia ma un “infausto inizio”, aveva detto la Presidente lettone, ed è difficile darle torto. Ricordando però che nella stessa occasione il Presidente estone aveva giustificato chi combatté al fianco dei nazisti: “si lottava per impedire il ritorno dell’Urss (…) una resistenza disperata per salvare le proprie famiglie”.
Il nazismo come male minore
Il nazismo come male minore, in questa lettura (una lettura diffusa, nei Paesi baltici, e i tentativi di contrastarla messi in atto dall’Unione europea non sembrano aver agito in profondità). Kallas ha poi continuato: “Gli estoni sono stati torturati, stuprati, la nostra cultura è stata cancellata e sostituita dalla cultura sovietica”. Lo sa anche per esperienza familiare: sua madre aveva solo pochi mesi quando fu deportata in Siberia insieme alla madre e alla nonna, mentre il nonno finì in prigione.
In occasione della mozione del Parlamento europeo del 2019 “sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa”, la Fondazione Feltrinelli ha pubblicato online molti interventi su questo tema e a essi rimando, nella sensazione però che non vi sia stata una reale prosecuzione del confronto. Nella sensazione, anche, che dovremmo sostenere molto di più le forze intellettuali che si battono contro le derive che ho evocato, e che dovremmo dedicare un’attenzione molto maggiore all’insegnamento reale della storia nei diversi Paesi.
Cioè alla visione del passato con cui vengono educati o diseducati i futuri cittadini europei. Nelle crisi che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando si è toccata con mano, credo, quell’assenza di una “opinione pubblica europea” su cui Habermas e altri hanno richiamato l’attenzione in più forme. E a favorire le divaricazioni vi sono anche i nodi che ho cercato di evocare.