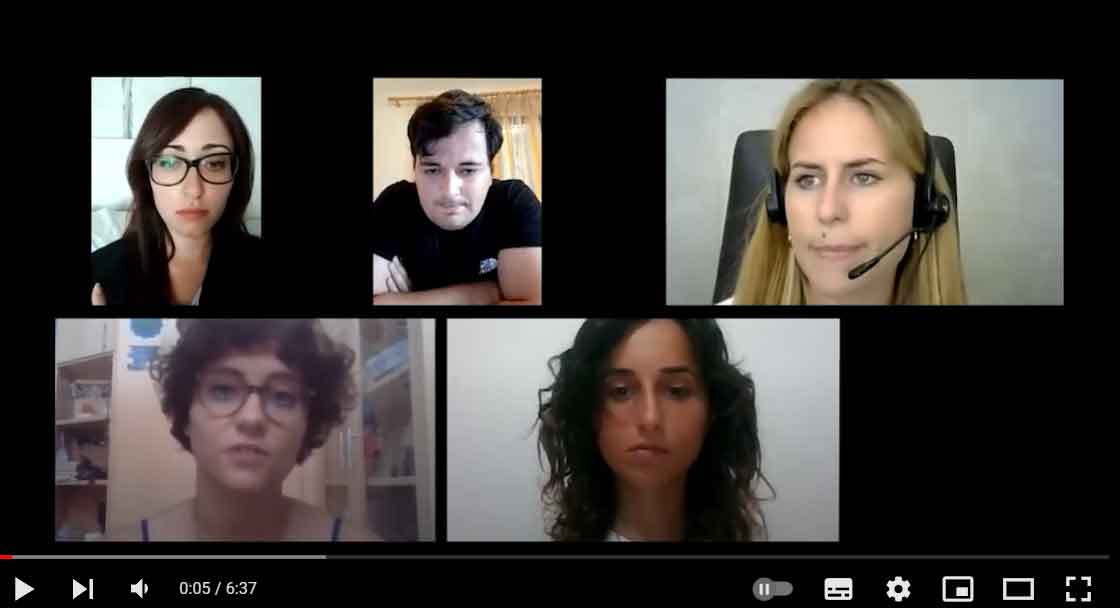La rivolta di Piazza Statuto a Torino. Riflettere su un evento storico significa ragionare sul complicato intreccio di continuità e discontinuità che lo attraversano. Ogni evento è inserito in un processo, e ogni processo è segnato da un evento (o più di uno) che ne costituisce il momento critico. L’evento, da questo punto di vista, segna un momento di apertura del processo e costituisce il punto di attrito e di ricombinazione di una serie di fattori insieme presupposti e non predeterminati.
In questo senso, la rivolta di Piazza Statuto è stata un evento fondamentale della cosiddetta Prima Repubblica. Come giustamente sottolineato, essa ha manifestato l’insorgenza di un nuovo attore, la cui eccezionalità si è espressa in un duplice modo. Da una parte, Piazza Statuto ha significato l’impossibilità di normare la soggettività di questo nuovo attore riconducendola entro i confini politici propri delle identità stabilite dal e nel contratto sociale. Dall’altra, tale eccezionalità ha investito la regolazione delle forme di lotta accettabili entro questo stesso contratto. Qui risiede la grande novità della rivolta di Piazza Statuto, non a caso sconfessata dalle strutture partitiche e sindacali del movimento operaio tradizionale.
In fondo, ciò che disturbava chi a sinistra parlava di «agenti provocatori» in relazione ai dimostranti torinesi non era tanto la durezza degli scontri, ma l’impossibilità di una loro ricomposizione politica.

Caduta governo Tambroni
Due anni prima, infatti, a Genova e in buona parte d’Italia la classe operaia aveva mostrato la sua forza, riuscendo a bloccare il congresso missino previsto nel capoluogo ligure e a far cadere il governo Tambroni. Anche in questo caso, si verificarono duri scontri di piazza, ma qui, a differenza che a Torino, la cornice antifascista permetteva alle forze politiche della sinistra di stabilire (e gestire) un orizzonte politico della sollevazione, e assicurava una cornice ideale di «legalità» (la Costituzione, nata dalla Resistenza) entro cui muovere la protesta.
A Torino, invece, questo non era possibile: anzi, la rivolta nasceva dall’impossibilità della ricomposizione, dall’emergenza della separazione, dalla frattura che si era prodotta nella società durante gli anni del boom economico. L’insorgenza di Piazza Statuto generava un’opposizione interna alla stessa classe operaia, divisa tra operai specializzati e operai non specializzati (l’«operaiomassa»). I primi, per quanto sfruttati, partecipi (anche se solo in minima parte) del boom; i secondi, esclusi dal miraggio della crescita e gettati nelle baraccopoli delle città industriali del nord Italia.
In sintesi, mentre a Genova l’antifascismo permetteva una sintesi politica delle istanze emerse dalla piazza, a Torino tale sintesi era preclusa dalla natura stessa dello scontro e dei soggetti che lo animavano.
Le caratteristiche della rivolta di Piazza Statuto – nuovo attore sociale, eccezionalità dei suoi connotati e delle forme della sua espressione conflittuale, difficoltà o impossibilità di ricomposizione politica delle sue istanze all’interno delle istituzioni date – sono comuni a diverse insorgenze contemporanee, al netto delle differenze che pure esistono e sono rilevanti. Che cosa è stato il Maggio ’68 se non una riproposizione di questi elementi, a Parigi come a Berkley? Per non dire dell’Italia, dove il «lungo Sessantotto» ha visto per un decennio la riproposizione di nuovi soggetti conflittuali, non rappresentati né rappresentabili nelle forme classiche della democrazia liberale.
Altre rivolte
Altre sollevazioni, seppure diverse per genesi e finalità, presentano la medesima cornice. Da una parte, le insorgenze spontanee, nate immediatamente dopo fatti di cronaca che hanno messo in luce le contraddizioni sistemiche delle società occidentali. Rientrano in questo quadro la rivolta di Los Angeles del 1992, gli incendi delle banlieue francesi nel 2005, la rivolta dei braccianti di Rosarno nel 2010, gli scontri che hanno infuocato l’Inghilterra nel 2011. Dall’altra, insorgenze più «strutturate» all’interno di movimenti sociali di ampio respiro, come nel caso di Genova 2001, delle proteste francesi contro il contratto di primo impiego nel 2006 e dei Gilet jaunes, del movimento Black Lives Matter.
Cosa accumuna tra loro queste sollevazioni, e cosa le rende simili a Piazza Statuto?
In primo luogo, il loro carattere di evento, nel senso prima attribuito a questo termine. Cioè, il fatto che esse si caratterizzano come momenti critici, esplosivi e conflittuali di processi di lungo corso. Da questo punto di vista, tali eventi emergono – letteralmente – in superficie, e rendono al tempo stesso evidente la profondità di ciò che li origina. In secondo luogo, la natura di questa «emersione»: nuovi soggetti, nuovi attori sociali prima ignorati o ridotti al silenzio, in ogni caso non contemplati, esclusi da qualsiasi progetto politico rilevante, dal contratto sociale, che si riprendono la scena manifestando l’impossibilità della loro inclusione alle condizioni date.
Raccontava uno degli operai protagonisti di Piazza Statuto: «la lotta di piazza nasce quando in fabbrica vedi che sei impotente a fare determinate cose. Allora lo fai per istinto, ma anche per far vedere alla gente che ci sei» (D. Lanzardo, La rivolta di Piazza Statuto, Feltrinelli, 1979, p. 118). Lo stesso può valere per le altre insorgenze sopra menzionate.
Certo, oggi l’impotenza non si manifesta in fabbrica, ma in tutta la società. Anche in questi casi, tuttavia, la rabbia diventa un modo per trasformare tale impotenza in potenza, uno strumento per affermare la propria esistenza materiale e le sue condizioni, spesso insopportabili. L’insorgenza, in fondo, è anche una lotta per il riconoscimento nel senso inteso da Frantz Fanon, un linguaggio tramite cui la subalternità prende parola fuori dalla semantica del «vittimismo». Comprendere tale linguaggio, piuttosto che relegarlo all’operato di semplici «agenti provocatori» in combutta col «nemico» (o peggio, semplificarlo nella cornice dello psicologismo) è il primo passo che permette di sottrarre all’insorgenza il suo carattere meramente evenemenziale, e di considerarlo come un atto politico inserito all’interno di un processo storico.